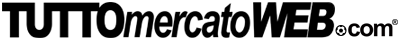M. Mannini: "Mantovani presidente innamorato dei suoi giocatori e della sua squadra. Sapevamo che a Wembley finiva il nostro ciclo"
 TUTTOmercatoWEB.com
TUTTOmercatoWEB.comCon 377 presenze raccolte dal 1984 al 1999 con la maglia della Sampdoria, Moreno Mannini è uno di quei giocatori che i sampdoriani non potranno mai dimenticare. Per rivivere quegli anni d'oro, in cui quella grande squadra che scendeva in campo con la maglia blucerchiata riuscì a vincere tutto o quasi, TMW Magazine ha intervistato proprio l'ex difensore del club ligure.
Moreno Mannini, la tua carriera nasce dalla gavetta: dopo aver giocato a Imola e Forlì arriva la chiamata del Como come primo trampolino di lancio. Anno 1982.
“Andai a fare un provino, accompagnato dal mio allenatore del Forlì e ricordo che giocai quest’amichevole dove non toccai un pallone. Tornai frustrato dalla mia prestazione, più che altro perché non me la passavano mai. Mi ero già vestito per tornarmene a casa mestamente mentre l’allenatore del Como Tarcisio Burgnich mi fermò e mi disse: per la velocità che tu hai se ti insegno a marcare diventi uno dei migliori difensori italiani. Mi prese e alla fine ha avuto ragione. Certo, fui fortunato perché lui essendo difensore della grande Inter fu un grande maestro per me”.
Due anni a Como e poi il grande salto alla Sampdoria.
“Anche qui, tutto nasce da un’amichevole. Nella fattispecie era Como-Sampdoria, presente Paolo Mantovani che voleva vedere Roberto Galia. Facemmo questa partita e alla fine presero me e lasciarono Galia ancora un anno al Como. Insomma, una serie di circostanze fortunate anche mi hanno portato a questa carriera”.
Anno 1984: la Samp all’epoca stava costruendo la squadra più forte della sua storia.
“C’erano le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 e Pietro Vierchowod era impegnato con la nazionale olimpica, per cui ho avuto l’opportunità di giocare tutte le partite di pre-campionato e quando tornò io che dovevo inizialmente essere panchinaro giocai titolare in coppia con lui”.
Al primo anno in blucerchiato sei agli ordini di Eugenio Bersellini. Che allenatore era?
“Apparteneva alla vecchia scuola allenatori, stesso allenamento, un po’ monotono visto che non cambiava di una virgola. Lo dipingevano come sergente di ferro ma aveva un cuore anche lui”.
Il passaggio alla Samp dalla realtà piccola di Imola è stato traumatico?
“Sinceramente no. Semmai è stato stimolante e io ho avuto la fortuna di giocare in 10-15 anni dove sono passati dei grandi campioni. Adesso l’Italia non è più come una volta dove i migliori stranieri ambivano a venire in Italia. Poi una volta c’erano al massimo 2-3 stranieri, adesso è una cosa vergognosa. Accendo la tv e vedo partite della Serie A senza italiani. E pensiamo di fare una nazionale forte?”
In quella Samp il punto di forza era il presidente Paolo Mantovani. Si troveranno più presidenti come lui?
“Un presidente innamorato dei suoi giocatori e della sua squadra. Lui ci voleva vedere felici, sapendo che se lo fossimo stati la squadra avrebbe fatto bene anche in campo. Creò una squadra prendendo dei giovani giocatori come me, Vialli, Mancini, Salsano e negli anni la squadra è diventata fortissima. La sua soddisfazione era creare una squadra partendo da giocatori semisconosciuti e ci è riuscito. Quella Samp si divertiva e faceva divertire e anche i non sampdoriani ci tifavano in Europa, mica come adesso dove tra tifosi di squadre italiane ci si gufa. Noi eravamo per tutti la squadra simpatia. Eccetto che per i genoani (ride, ndr)”.
C’è un aneddoto legato a Paolo Mantovani?
“Paolo Mantovani era un personaggio che oltre a venire a giocare a carte con noi la sera, venire al ristorante con noi. Quando partivamo per giocare in Europa, quando passavamo con l’aereo sopra Ginevra diceva: “Vedete? Chi sposa mia figlia quella casa laggiù è sua”. Personaggio fantastico, di una simpatia e di un affetto unico nei nostri confronti. Per lui noi eravamo la priorità: ad esempio diceva alla sua segretaria ogni volta che si presenta un giocatore cancella tutti gli appuntamenti e fai venire il giocatore. Non come adesso che i presidenti sono irraggiungibili, devi prendere appuntamento. E poi lui si divertiva a giocare con noi con i contratti”.
In che senso?
“Nessuno ha mai discusso un contratto con Paolo Mantovani. Arrivava con il contratto fatto e poi si divertiva a mettertelo davanti, girato al rovescio e ti diceva: quanto pensi di valere? Quanto vorresti guadagnare? E ti metteva in difficoltà, perché avevi paura di dire troppo, di dire una cavolata. Che poi il contratto era già firmato da lui, per cui se chiedevi una lira in più non te la dava mica, ma se ti aspettavi centomila lire in meno lui comunque ti dava quanto aveva già stabilito. Il suo divertimento era cercare di capire quanto tu ti valutavi. A Cerezo gli portò un contratto scritto in un tovagliolo al ristorante, per dire. E poi odiava i procuratori, diceva sempre che chi doveva guadagnare erano i giocatori, non gli intermediari. L’unica volta che un nostro giocatore si presentava col procuratore, successe con Pellegrini, lo mandava via. L’unica eccezione la concedeva ai giocatori stranieri, che magari non conoscendo la lingua ne avevano bisogno”.
Un gruppo storico che è rimasto unito nonostante le richieste dalle big. Siete rimasti per Mantovani?
“Assolutamente sì. Eravamo talmente legati a lui che avremmo fatto qualsiasi cosa. Ai nostri tempi c’era più serietà. Le società non andavano a bussare dal giocatore, ma passavano prima dall’altro club. Mantovani ci raccontò dopo che una mattina alle 6 si presentò a casa sua Agnelli che voleva comprare me, Vierchowod, Vialli e Mancini. Per noi quattro aveva messo sul piatto 50 miliardi di lire. Questo non ce l’aveva mai detto, lo fece solo anni dopo, una volta vinto lo scudetto nel 1991. Ci confidò che aveva rifiutato quell’offerta perché voleva provare a vincere con la Samp”.
Rimpianti per non essere andato alla Juventus?
“No. Eravamo talmente legati tra di noi, d’altronde. Facemmo un patto dove nessuno avrebbe lasciato la squadra prima di vincere lo scudetto. E poi c’era Boskov che ci faceva divertire. Lui non aveva la presunzione di dire cosa fare a grandi giocatori, li metteva semplicemente nelle condizione di far bene, gestiva la testa”.
I maligni dicono che erano i senatori facevano la formazione.
“Boskov era bravissimo a far credere questo. Poi alla fine faceva sempre quello che gli pareva. Mi ricordo che dovevamo fare una partita di Coppa delle Coppe contro il Malines, dove c’era una pioggia battente. Andammo a parlare con Boskov chiedendogli di non far giocare Cerezo perché la domenica avevamo una partita più importante. Lui ci disse: sì sì, avete ragione. Andiamo in campo e vediamo nella formazione: Cerezo titolare”.
Personaggio d’altri tempi, Vujadin Boskov.
“Non puoi non volergli bene, ma era furbo. Aveva capito di avere a che fare con dei giocatori bravissimi, però doveva lasciargli una certa libertà e fare in modo di non segregarli negli atteggiamenti e nei comportamenti altrimenti non avrebbe ottenuto risultato. Arrivammo al punto che avevamo sette nazionali. E ricordo che Sacchi, che era il ct, diceva più di una volta: se vi avessi allenato io per quanto eravate forti sapete quanto avreste vinto in più? Vialli gli rispondeva: Arrigo, chi lo dice che invece che fare l’allenamento alle 11 col sorriso sulle labbra potevamo rendere allenandoci magari alle 9 in maniera più rigida? Non c’era la controprova”.
Che allenatore è stato Sacchi?
“Un allenatore incredibile, un perfezionista. Ho imparato da lui tantissimo anche se avevo più di trent’anni. Ho visto curare i falli laterali, cosa mai vista nella mia carriera”.
Insomma, un’altra scuola rispetto a Boskov.
“Boskov la domenica mattina faceva questo discorso: te Moreno, te Vierchowod marcate questi giocatori, togliete palla e date a Toninho Cerezo. Poi lui butta avanti che tanto Vialli e Mancini fan gol. Era un grande a livello psicologico: quando perdevamo si incazzava se non ridevamo, dovevamo andare fuori a festeggiare mentre quando vincevamo ci massacrava. Diceva: se avete perso e in più infierisco non recuperate più; invece quando vincete posso pure massacrarvi perché dopo che avete vinto potreste fare anche un’altra partita dopo 2 ore”.
Dopo Boskov, Eriksson. Due personalità diverse.
“Persona bravissima, un signore. Non l’ho mai visto arrabbiato. Pensa che lo chiamavi “mister” e lui diventava rosso. Molto bravo tatticamente”.
Menotti invece è stato una meteora.
“Ha portato un paio di giocatori argentini sul quale è meglio lasciar perdere. Per fare bene doveva avere in mano una squadra superiore alle altre di due spanne. Con lui abbiamo fatto una preparazione ridicola, subito col pallone mai fatto una salita, mai fatto una corsa. Diceva che il campo non aveva salite quindi era inutile farle. Noi d’altro campo non eravamo più la stessa Samp, nonostante il figlio di Paolo Mantovani, Enrico, continuava a prendere buoni giocatori”.
Enrico Mantovani molto sfortunato e nemmeno amato dai tifosi.
“Sì è trovato lì che in realtà il padre non voleva che i figli proseguissero la sua presidenza. Non si presentò bene in quel momento lì, ma secondo me ha dato tutto quello che poteva dare ma si è trovato in una situazione che non c’era dentro. Mentre la figlia, Francesca, faceva parte di noi, era sempre con noi mentre Enrico era in America a studiare e quando è tornato non conosceva l’ambiente. Si è anche dovuto affidare a personaggi che non sempre erano all’altezza e siamo retrocessi con una squadra che non era nemmeno da retrocessione”.
Allenatore Spalletti, Com’era all’inizio della sua carriera?
“Io ci ho litigato e ho lasciato la Samp. Eppure tecnicamente e come preparazione lo ritengo il migliore che abbia avuto. Però ci siamo scontrati su situazioni più personali che altro. Mi spiace aver litigato, ci sono stato male e poi non andava niente a beneficio della Sampdoria. In quel momento mi disse cose che mi ferirono, del tipo che giocavo solo per fare le presenze. Come, io che in questa squadra ci sono cresciuto? Adesso comunque abbiamo chiarito, siamo tornati in buoni rapporti”.
Sei così emigrato in Inghilterra, al Nottingham Forest.
“Avevo 38 anni, in realtà non volevo neanche andare. Ero ormai tornato a casa, mi è arrivata una telefonata il 31 luglio da David Platt che era diventato allenatore e mi disse: vieni a giocare con me. Io ero stuzzicato dall’avventura in Inghilterra per imparare la lingua e chiedo: quando inizia il campionato? E lui: il 2 agosto. Cioè, due giorni dopo la chiamata”.
Che esperienza è stata?
“Platt mi voleva fare un quadriennale, io a 38 anni non avevo intenzione di stare così a lungo e ho optato per il primo, anche per vedere come mi sono trovato. E infatti mi sono trovato male, soprattutto con i giocatori. Attilio Lombardo, che all’epoca era al Crystal Palace, mi aveva avvertito. I giocatori per il fatto che io arrivassi dall’Italia e che David in un suo libro ha scritto che il difensore più furbo che abbia incontrato ero io, non mi vedevano bene. Quando gli spiegavo le cose facevano finta di non capire, mi hanno messo il bastone tra le ruote e io mi sono stufato, tanto che il 6 gennaio ero a casa”.
Anche Nottingham non era il massimo.
“Lasciamo perdere, a parte Londra in Inghilterra non c’è nulla. Hanno come mentalità quella di bere, sin dalle 4. Poi la sera è tutto chiuso. Per non parlare del tempo, sempre piovoso”.
E con l’inglese poi come te la sei cavata? L’hai almeno imparato?
“Pochissimo, anche perché avendo il club preso anche Matrecano e Petrachi e andando spesso a mangiare al ristorante italiano non è che mettevamo in pratica molto inglese”.
Soddisfazione più grande: scudetto o cavalcata in Champions?
“Per lo scudetto ci stavamo preparando. Avevamo perso una finale di Coppa delle Coppe, poi vinta l’anno dopo con l’Anderlecht, quindi eravamo consapevoli di poter vincere il campionato. Pensare invece di arrivare alla finale di Coppa dei Campioni al primo anno è stata una sorpresa. Col Barcellona in quella finale a Wembley potevamo vincere, che peccato”.
Avevate capito che il ciclo era finito?
“Sì, sapevamo che a Wembley finiva il nostro ciclo. Vialli era ormai ceduto alla Juve, il nostro presidente stava morendo. Capimmo che in quella partita si chiudeva un cerchio. Quella partita fu un’esperienza comunque indimenticabile. E nel calcio ci sono cose che non puoi comprare come le emozioni. Ricordo con piacere anche l’emozione che provai alla seconda partita in Serie A al San Paolo a marcare Diego Armando Maradona. Quella era la sua prima partita in campionato a Napoli e lo stadio era una bolgia, al punto che non riuscivi a sentire nemmeno il tuo compagno di squadra a dieci metri”.
Capitolo Nazionale: rimpianti per aver iniziato tardi?
“All’epoca erano molto conservativi, c’erano delle gerarchie. Con Vicini avevano la priorità i giocatori che avevano fatto l’Under 21 con lui. Quando mi ha convocato Sacchi ero in un momento di forma tale che non potevano non chiamarmi. Diciamo che ci potevo stare prima in Nazionale”.
Di cosa ti occupi adesso? Sei rimasto nel mondo del calcio?
“Ho dedicato il mio tempo alla famiglia. Avevo dei bambini piccoli e ho preferito non allontanarmi più. Sono molto legato a Imola. A Genova sono stato bene ed è la città dove sono nati i miei figli ma è qui che ho radici e con tutto il rispetto le amicizie fatte a 20 anni sono diverse a quelle con le quali sei cresciuto”.

Partita IVA 01488100510
© 2025 sampdorianews.net - Tutti i diritti riservati